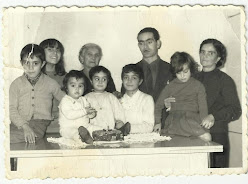di G.D. Amendolara
☙______________❧
Storia inserita in Archivio > Storie Chiaromontesi
Mi scuso con i lettori per la possibile presenza di errori ortografici, ma nonostante il poco tempo a disposizione, non ho voluto mancare nel ricordare un grande personaggio Chiaromontese nel giorno del ventesimo anniversario della sua scomparsa, il 28 dicembre 2004.
"Uno, due, tre
evviva u Re"
Se dovessi parlare di colui che sto per raccontare come farebbe chiunque, allora comincerei così…
C’era una volta Maumà,
che da sobrio tanto odiava questo nome.
Lo conoscevano tutti, quasi fosse il personaggio più importante del paese.
Amava esibirsi con i suoi abiti eccentrici, i suoi balletti e dimostrando ai più giovani che lo invitavano a giocare a calcio quelle peripezie che tanto lo resero celebre nelle storiche partite tra paesi limitrofi, e non solo.
Ecco…
Continuerei così per ore, giorni, entrando nei minimi particolari, anche quelli sconosciuti a molti, tralasciando però quegli aspetti importanti che mi hanno spinto a scrivere di lui, per questo ricomincio…
C’era una volta un Uomo,
che la vita ebbe segnata sin dal giorno della nascita.
Pagò caramente la disobbedienza verso quella madre amorosa e desiderosa di vederlo realizzato altrove, finendo sotto il bersaglio di chi cuore non aveva, come colui che lo pagò del duro lavoro donandogli del cibo da mangiare insieme ai maiali.
Conobbe così il peggiore dei suoi mali, colui che lo trasformò in Maumà, per i troppi un ubriacone abitudinario, un disadattato, un giullare del quale ridere durante le sue bizzarrie.
Cominciò così a cercare la felicità donandone agli altri in mille modi possibili travestendosi in modo eccentrico, con i suoi balletti memorabili e accettando persino sfide pericolose, tra le quali quella che lo immortalò in una foto rimasta per anni nella bacheca in piazza.
Era appassionato di calcio, soprattutto giocato, tanto da definirsi Re, inconsapevole che quel titolo gli sarebbe calzato a pennello, perché di animo buono e nobile.
Odiava nel frattempo quel nomignolo datogli per sfottò, dimostrando appena possibile di non essere ciò che consideravano.
Amava Chiaromonte, i Chiaromontesi e la vita, tanto da salvarne tante, di vite, grazie al suo essere donatore di sangue universale, volontario e disponibile, sempre, anche quando, armato di pala, era il primo a spalare la neve per le vie del paese, quando di neve ne cadeva tanta.
D’un tratto però il peggiore dei suoi mali gli presentò il conto e lo ammalò malamente e, nonostante la resistenza e l’attaccamento alla vita, lo spense in un freddo giorno d’inverno.
Chiaromonte perse così il suo RE, uno tra i più grandi Chiaromontesi della storia, un uomo buono, educato, disponibile, un Signore anche con coloro che in vita lo ignorarono.
Lo conoscevano tutti, quasi fosse il personaggio più importante del paese.
Amava esibirsi con i suoi abiti eccentrici, i suoi balletti e dimostrando ai più giovani che lo invitavano a giocare a calcio quelle peripezie che tanto lo resero celebre nelle storiche partite tra paesi limitrofi, e non solo.
Ecco…
Continuerei così per ore, giorni, entrando nei minimi particolari, anche quelli sconosciuti a molti, tralasciando però quegli aspetti importanti che mi hanno spinto a scrivere di lui, per questo ricomincio…
C’era una volta un Uomo,
che la vita ebbe segnata sin dal giorno della nascita.
Pagò caramente la disobbedienza verso quella madre amorosa e desiderosa di vederlo realizzato altrove, finendo sotto il bersaglio di chi cuore non aveva, come colui che lo pagò del duro lavoro donandogli del cibo da mangiare insieme ai maiali.
Conobbe così il peggiore dei suoi mali, colui che lo trasformò in Maumà, per i troppi un ubriacone abitudinario, un disadattato, un giullare del quale ridere durante le sue bizzarrie.
Cominciò così a cercare la felicità donandone agli altri in mille modi possibili travestendosi in modo eccentrico, con i suoi balletti memorabili e accettando persino sfide pericolose, tra le quali quella che lo immortalò in una foto rimasta per anni nella bacheca in piazza.
Era appassionato di calcio, soprattutto giocato, tanto da definirsi Re, inconsapevole che quel titolo gli sarebbe calzato a pennello, perché di animo buono e nobile.
Odiava nel frattempo quel nomignolo datogli per sfottò, dimostrando appena possibile di non essere ciò che consideravano.
Amava Chiaromonte, i Chiaromontesi e la vita, tanto da salvarne tante, di vite, grazie al suo essere donatore di sangue universale, volontario e disponibile, sempre, anche quando, armato di pala, era il primo a spalare la neve per le vie del paese, quando di neve ne cadeva tanta.
 |
| Il Re, qualche settimana prima della sua scomparsa |
D’un tratto però il peggiore dei suoi mali gli presentò il conto e lo ammalò malamente e, nonostante la resistenza e l’attaccamento alla vita, lo spense in un freddo giorno d’inverno.
Chiaromonte perse così il suo RE, uno tra i più grandi Chiaromontesi della storia, un uomo buono, educato, disponibile, un Signore anche con coloro che in vita lo ignorarono.
"U Rè"
Chiaromonte 1947
Potenza 2004
___________



.jpeg)